Max Manfredi, tu che con le parole in versi hai un rapporto che si può definire professionale, tu,
ora, dimmi, cosa è oggi, ammesso che ancora esista, la poesia?
La poesia è ammessa dalla realtà. I produttori di poesie sono legioni, caterve, miriadi. Anche se fosse vietata, ed esistessero i Tutor per spiare i contravventori, la poesia ci sarebbe lo stesso. Tollerata com’è ora, spopola ovunque. Esiste. È sempre esistita persino quando era vietata, o sottoposta a censure severissime. Nella Russia sovietica esisteva sotto forma di samizdat. Io con le parole in versi (cioè con la poesia, perché ogni altra definizione è discutibile nel suo assunto, se non dal punto di vista emotivo. Io preferisco quella famigerata della Emily Dickinson) ho un rapporto prima artigianale, poi professionale.
Ogni poeta, però, lo ha. Nel mio caso la disciplina è ibrida: i versi vivono nella musica, la musica si compone di timbri, melodie ed armonie, ritmi, che devono fondersi con la melodia, col suono, col senso e con il ritmo del verso. La tua domanda è ingenua e capziosa (scegli tu). Evidentemente se tanta gente si sfoga coi versi (a volte con sensibilità e competenza, a volte nell’ignoranza, sostituendo il legittimo orgoglio dell’artigiano con una presunzione generica, e il senso della folgorazione con un’applicazione pedissequa) la poesia è necessaria. Cosa significa poi “esistere” della poesia? Immagino tu ti riferisca ad una vita pubblica. Lì cominciano i problemi. Se scrivo versi, o sono paghi di sé stessi, finché qualcuno non “tradisce” questa intenzione, rendendoli pubblici, magari quando sono morto; oppure sono fatti per essere letti o ascoltati. Da quali pulpiti, da quali tribune, in quale speaker’s corner? In tempi passati bisognava scriverli, stamparli e, come si dice con brutta parola, “editarli”.
Oggi basta pubblicarli su qualche blog, et voilà, son lì, brillano sullo schermo, a disposizione di qualsiasi ozioso o critico che voglia commentarli. Democrazia del dire? Mica tanto. Tant’è vero che ai poeti (intendo con questo termine i produttori di poesia, e considero la definizione poesia scevra da ogni velleità assiologica) questo non basta. Vogliono leggerli in piccole platee, vogliono che siano pubblicati, i più abbienti li regalano agli amici o ai loro sottoposti come opinabili strenne. Qualcosa di simile sta avvenendo per le canzoni. Anche qui la pletora dei produttori di canzoni si espande giorno per giorno. Anche qui i luoghi pubblici si fanno sempre più ardui e striminziti. Anche qui alla universale possibilità di autarchia (produrre non costa praticamente nulla) si oppone una gincana di caste kafkiane, volte a neutralizzare la valenza pubblica del prodotto, a disperderla.
Ma nonostante le regole (ad esempio fiscali) siano chiaramente volte ad impedirne l’esistenza sociale, la canzone continua a brulicare non solo negli alloggi privati, ma anche nei circoli e addirittura, se si è abbastanza noti o si hanno amici assessori, nelle piccole piazze. Eppure la gente continua, a volte non è capace ma lo fa, lo fa. E quindi tutto questo esiste, esiste in barba e in margine alle leggi e alle convenienze della società. Anche la “poesia” te la trovi dappertutto.
Ritieni che possa ancora avere una finalità, per così dire, concreta nella vita di chi ancora ne legge?
La finalità è nella sua stessa smania, fame vampirica, di esistere. Il suo fine è lei stessa e questa è la sua concretezza. A rigore non si può nemmeno parlare di parassitismo sociale. Certo, il poeta - che, per definizione, scrive dei versi invece di fare qualcosa di utile alla società ed al mercato, o almeno di ammesso; e senza aumentare nemmeno troppo il Pil (i cantautori almeno spendono in birre e benzina) - il poeta può essere considerato un parassita dell’organismo sociale. Ma attenzione, solo se ci si riconosce nella postura astratta di una società come organismo. Cambiando visuale è invece l’enorme parassita della società che succhia il misero Graal del sangue poetante, individuo per individuo. Così come succhia il sangue a tutti i cittadini, e soprattutto le loro tentazioni di energia psichica. Ci è però più facile pensarlo una volta che - per chissà quale diabolico motivo - abbiamo deciso di incoronare qualcuno come poeta. Lì scatta la sindrome della Quercia Caduta di Pascoli: “Era pur grande! Era pur buono!” “Se non gli avessimo rotto tanto i coglioni”. E non si ricorda di quanto i coglioni li rompeva lui, anima santa ed adorabil piede.
“Quando” è una poesia d’amore, o meglio di “disamore”. Nasce dalla delusione, dallo sconforto dato dalla delusione. Un mondo che sembra sgretolarsi, e pure le stelle perdono tutto il loro valore. Viene richiamato anche il mito di Orfeo ed Euridice; a quel punto l’amore perso acquisisce in se stesso la linfa di cui nutrirsi. Il poeta innamorato resta solo, eppure continuerà a cantare della sua Euridice, pur se, proprio per amore, persa per sempre.
Le stelle infatti sono chiamate continuamente a testimone dei giochi letterari di C. G. Stelle uguale costellazione mitologica. I miti sono evocati ed assenti, dove assenti (secondo la visuale “funzionale” dell’autore) significa inutilizzabili. L’amore è un bene rifugio, il rifugio è perduto. Il bene, fuggitivo ed ironico, anche se - per così dire - continua a vedere “mezzo piena” la coppa dell’Utopia.
dalla PREFAZIONE
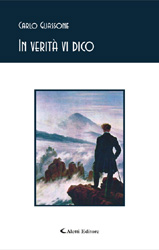 immagine di copertina
immagine di copertina